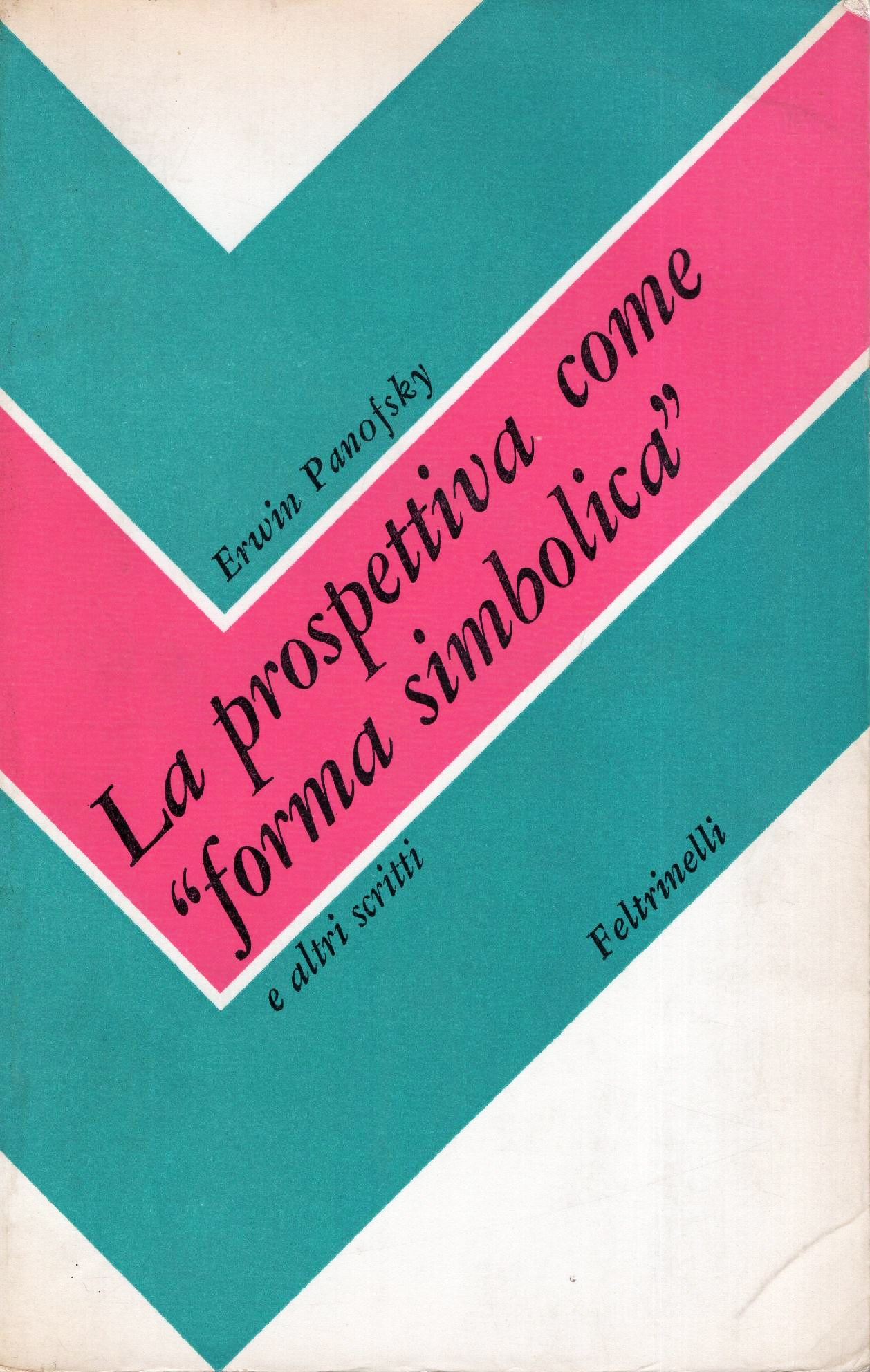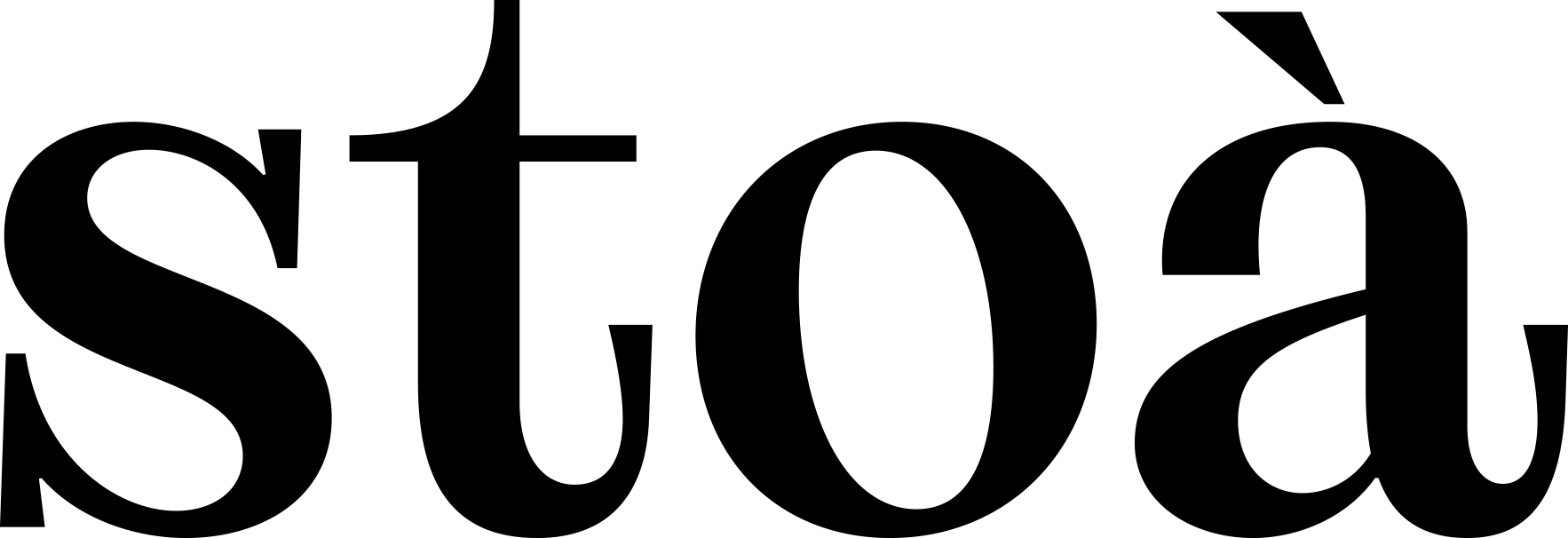︎︎︎ Biblioteca
STOÀ
STOÀ 2. Disegni
La prospettiva come
“forma simbolica” e altri scritti
Erwin Panofsky
1961
Percezione, rappresentazione. Idee di mondo nella concezione dello spazio
Assodato come il legame tra i modi della rappresentazione e la nostra percezione del mondo sia del tutto simile all’intimo e antico rapporto tra linguaggio e pensiero[1], in questo intenso saggio Erwin Panofsky compie un’accurata disamina critica della concezione e costruzione dello spazio nelle pratiche artistiche dall’antichità al Rinascimento.
Il suo obiettivo è dimostrare come la rappresentazione prospettica sia una tecnica che diverse culture hanno nel tempo conquistato, affinato o reinventato, assecondando e riflettendo la propria idea di mondo: una tecnica all’interno delle cui logiche e dei cui meccanismi applicativi riverberano precisi universi semantici.
Così, per esempio, mentre la prospettiva angolare del Mondo Antico misura le grandezze visive in proporzione agli angoli – consapevole della curvatura della retina su cui è proiettata l’immagine nel momento della sua percezione – la prospettiva piana di origine rinascimentale approssima consapevolmente la curvatura retinica proiettando le immagini su una plana tabella.
Tutto ciò avviene in favore di una maggiore astrazione.
La rottura delle relazioni fondamentali dell’organizzazione spaziale del mondo antico è infatti perpetuata in favore di una visione che risolva tutti gli elementi e le forme disposte nello spazio all’interno di un unico, omogeneo e misurabile quantum continuum.
Le logiche dello spazio percettivo – anisotropo, disomogeneo e finito – lasciano così il posto alle logiche matematiche dello spazio geometrico – isotropo, omogeneo e potenzialmente infinito: che modo delizioso e raffinato di raccontare il grande capovolgimento di pensiero che è stato il Rinascimento, con l’introduzione alla Modernità!
Ma, nella trattazione di Panofsky, è interessante anche la lettura del processo che ha portato al concepimento della visione prospettica per come oggi la conosciamo, che trova nel Medioevo un fondamentale momento di rottura col passato. Nell’antichità, «la totalità del mondo» è sempre stata «qualcosa di fondamentalmente discontinuo», i corpi e lo spazio[2]sono sempre stati divisi, e le figure si sono sempre disposte in ensamble plastici vincolati da rapporti di prossimità. Invece, già nella pittura romanica esse appaiono libere da «vincoli mimetico-corporei e prospettico-spaziali», stagliandosi su un piano che spesso è un fondale d’oro, in analogia con la metafisica della luce del Neoplatonismo pagano e cristiano secondo cui «lo spazio non è altro che la luce più sottile» – come scrive Proclo[3].
Questa pittura riduce alla superficie sia i corpi che lo spazio e, così facendo, «suggella e rinsalda per la prima volta l’omogeneità tra questo e quelli»[4]. Paradossalmente, proprio il disfacimento dell’antica concezione spaziale coincide con la nascita della concezione unitaria del piano di rappresentazione e, per analogia, con la prima concezione del mondo come un continuum omogeneo, seppur ancora «non misurabile, anzi privo di dimensioni»[5].
Se inizialmente lo spazio e i corpi appaiono legati da un vincolo esclusivamente concettuale, soprattutto attraverso la scultura dell’alto Medioevo, tale legame si stacca dalla superficie, con la costruzione di nicchie, portali e baldacchini[6]. Ed è solo nel Trecento maturo che la superficie pittorica non viene più concepita come «la tavola su cui vengono disposte le forme delle singole cose e figure» ma come «il piano trasparente attraverso il quale noi possiamo pensare di guardare in uno spazio aperto per quanto circoscritto in tutte le direzioni»[7]. Ulteriori passaggi fondamentali riguardano poi l’unificazione del punto di fuga e l’introduzione del piano di base spesso raffigurato con una pavimentazione a scacchi, antesignana della griglia misuratrice omogenea e infinita della modernità. Infine, con la messa a punto della cosiddetta «costruzione legittima» – fondata sulla convinzione che «il quadro è una intersezione piana della piramide visiva»[8]– si arriva a determinare una prospettiva matematicamente esatta, definendo un metodo univoco per misurare gli intervalli lungo la profondità del campo visivo.
Questo definitivo passaggio da spazio psicofisiologico a spazio matematico, se da un lato oggettivizza un modo di raffigurare lo spazio, dall’altro, attraverso la scelta arbitraria e soggettiva del punto di vista, ripropone continuamente alla riflessione artistica il problema del senso in cui impiegare questo metodo[9].
Così si spiegano, per esempio, le differenze tra la prospettiva nordica e quella italiana, descritte da Panofsky attraverso il paradigmatico confronto tra il San Gerolamo nello studio di Antonello da Messina e l’omonimo quadro di Albrecht Dürer. Mentre il primo sceglie un punto di vista centrale, simmetrico e molto distante dagli oggetti, conferendo carattere aulico alla composizione, il secondo sceglie un punto di vista decentrato, asimmetrico e ravvicinato, ricercando un’atmosfera intimistica e meno solenne.
La tecnica della prospettiva piana contiene dunque in sé tutti i sentimenti del suo tempo, facendosi largo nell’antitesi tra norma e arbitrio, soggettivo e oggettivo, e rispecchiando sia la rinuncia alla concezione aristotelica della Terra al centro dell’Universo, sia la conquista del «concetto di un’infinità non soltanto prefigurata in Dio, ma realizzata di fatto nella realtà empirica»[10].
«La prospettiva geometrico-euclidea – conclude Panofsky – sembra ridurre il divino a un mero contenuto della coscienza umana, ma insieme amplia la conoscenza umana sino a renderla capace di accogliere e contenere in sé il divino. Non è pertanto un caso che questa concezione prospettica dello spazio si sia imposta due volte nel corso dello sviluppo artistico: la prima volta come segno di una fine, quando venne meno l’antica teocrazia, la seconda volta come segno di un inizio, quando sorse la moderna antropocrazia»[11].
Non resta che chiedersi quale sarà il prossimo salto che riuscirà a decostruire questo modello antropocentrico, per costruirne uno nuovo, finalmente consapevole della necessaria ri-conquista di una posizione eccentrica del nostro sguardo sul mondo e sulla natura, forse meno assoluta, altrettanto potente ma sicuramente più mite. Recensione di Giuseppe Tupputi
[1] Franco Farinelli, I segni del mondo. Immagine cartografica e discorso geografico in età moderna, Varese, Academia Universal Press, 2009, p. 123.
[2] Erwin Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica” e altri scritti, [trad. it. Enrico Filippini, a cura di Guido D. Neri, con una nota di Marisa Dalai] Milano, Feltrinelli, 1961, p. 50. Ciò è vero, per esempio, sia quando Democrito costruisce un modello di mondo composto di particelle puramente corporee, per poi postulare un vuoto infinito; sia quando Platone contrappone agli elementi riconducibili a forme uno spazio informe; sia quando Aristotele attribuisce sei dimensioni allo spazio (sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra), pur riconoscendo i singoli corpi sufficientemente determinati da sole tre dimensioni (larghezza, altezza, profondità).
[3] Ivi, pp. 50-51.
[4] Ivi, p. 53.
[5] Ivi, p. 52.
[6] Ivi, p. 55.
[7] Ivi, p. 56.
[8]Ivi, p. 62.
[9] Ivi, p. 66.
[10] Ivi, p. 64.
[11] Ivi, pp. 69-70.
︎︎︎Biblioteca