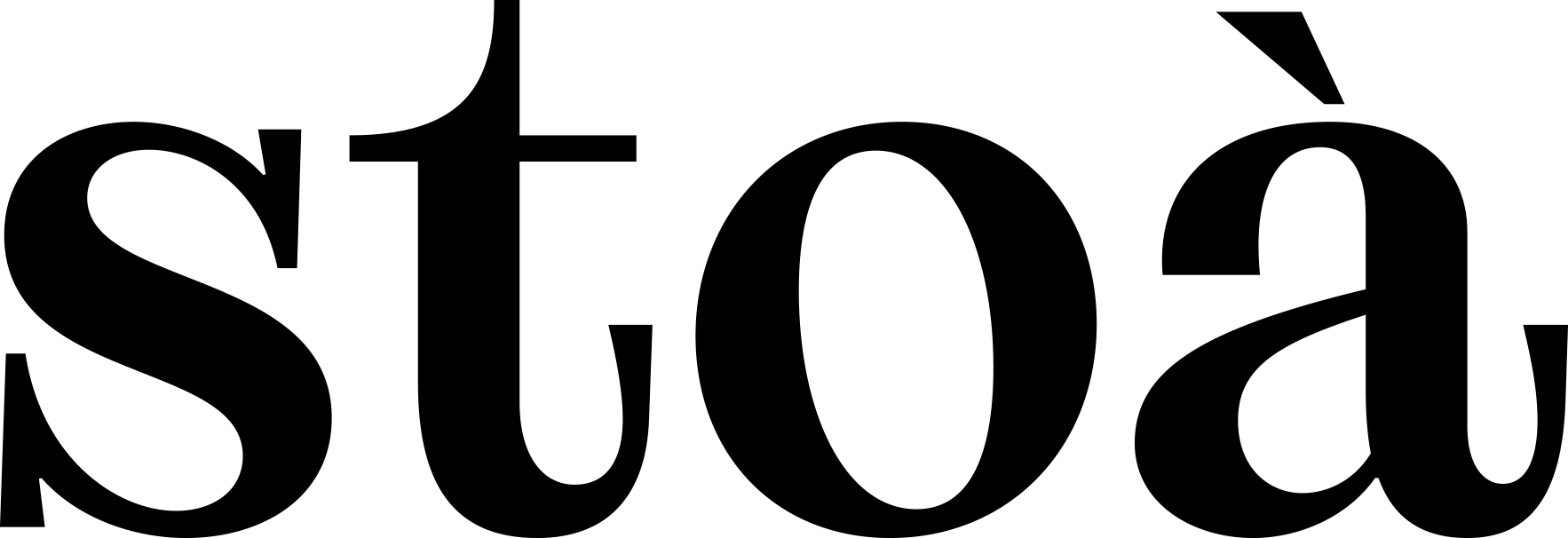︎︎︎ Call for Abstracts
Stoà Journal n. 16, anno IV, 2/3, Estate 2026
OBIETTIVI, OBJECTIVES
La riflessione proposta si concentra questa volta sul perché più che sul come: non tanto, o non soltanto, sugli strumenti
e sulle modalità didattiche che regolano l’insegnamento del progetto di architettura, quanto piuttosto sugli obiettivi per cui quelle stesse modalità vengono strutturate e sui mezzi attraverso cui vengono perseguite. Tali obiettivi, se da un lato sono fissati in termini di competenze professionali da una serie di regolamenti di carattere locale, nazionale e sovranazionale, dall’altro riguardano dal punto di vista culturale, in primo luogo, l’idea di architetto e di architettura che si vuole trasmettere, implicando dunque la capacità stessa delle istituzioni accademiche e delle comunità scientifiche che le sostengono di contribuire alla definizione di questa idea.
Qual è l’idea di architetto che è al centro dell’identità culturale di una scuola, della programmazione di un corso di studi o del progetto di un laboratorio di progettazione? La risposta non è affatto semplice, e non solo per la graduale affermazione di una pedagogia trasformativa e di una didattica progressiva, con cui si è complicato il ruolo tradizionale del reflective practitioner, ma anche per tutta una serie di cambiamenti sociali, economici e culturali che, giorno per giorno, portano a una continua ridiscussione di quali siano il ruolo dell’architetto e il lavoro del progettista nella società contemporanea.
Le crisi climatiche e ambientali, le trasformazioni e i
conflitti delle società contemporanee, le frammentazioni e precarizzazioni del mercato del lavoro, l’emergere di nuove modalità di impegno intellettuale e di partecipazione civile, sono tutte questioni che, ponendosi come nuovi parametri nell'azione del progetto, stabiliscono nuovi obiettivi per la formazione del progettista. Il nuovo numero della rivista, attraverso una ricognizione di pratiche didattiche ed esperienze pedagogiche in corso, indagherà diversi gradi di rimodulazione degli obiettivi formativi e differenti modalità di applicazione pratica.
In questo senso, tre sono gli argini tematici entro cui si propone di raccogliere riflessioni critiche:
Obiettivo come fine
Architetto, progettista, practitioner, facilitatore, intellettuale: le scuole di architettura, oggi, non sono più monolitiche nell’individuare un ruolo di riferimento come obiettivo della formazione superiore. Quali sono oggi i modelli prevalenti
e quelli a cui guardare in futuro? A quali nuove competenze professionali occorrerebbe guardare e con quali ulteriori ambiti disciplinari sarà necessario interagire? Qual è l’impatto della pedagogia trasformativa nell’identificazione di un ruolo chiaramente definito?
Obiettivo come mezzo
Obiettivi formativi e modalità didattiche sono strettamente correlati, se non co-dipendenti. Al variare degli obiettivi, come evolvono le modalità didattiche corrispondenti? Quali curriculum formativi occorrerebbe introdurre oggi? Quali metodologie didattiche andrebbero recuperate o sperimentate rispetto a questi nuovi obiettivi? In che misura l’apporto di ulteriori discipline potrebbe concorrere alla strutturazione di questa evoluzione?
Obiettivo come strumento
L’obiettivo non rappresenta solo un fine ideale, ma, in qualità di modello di riferimento, può essere assunto come strumento per una didattica operativa che può assumere caratteristiche differenti. In che termini la rimodulazione degli obiettivi può essere assunta come caratterizzante per la definizione di una serie di esercizi didattici? Qual è il ruolo operativo dei modelli di riferimento in questo senso e quali possono essere i tempi di necessaria sedimentazione e sperimentazione didattica alla luce dei risultati di volta in volta raggiunti?
Sono accettati contributi capaci di mettere in campo una o più azioni tra le seguenti:
→ riconoscere tratti comuni nelle molteplici esperienze internazionali contemporanee;
→ esemplificare, attraverso la loro concettualizzazione, specifiche esperienze didattiche, attraverso resoconti, dialoghi e interviste con docenti di fama internazionale, capaci di diventare espressioni sintetiche ed efficaci di un saper fare scuola progettato e progettante;
→ tracciare un limite condivisibile dalla comunità scientifica di riferimento entro cui posizionare criticamente idee e progetti (di didattica).
L’abstract di massimo 1500 battute, corredato da tre immagini e un profilo biografico di 350 battute per ogni autore dovrà essere inviato in unico file .doc all’indirizzo: redazione@stoajournal.com
︎︎︎Scarica la call
︎︎︎Norme Editoriali
︎︎︎Deadline: 01/12/2025
Gli autori dei contributi accettati verranno informati entro il 15/12/2025.
Non saranno accettati abstract da parte di autori i cui contributi sono già stati pubblicati in stoà 11, 12, 13, 14, 15
La call è aperta a dottorandi, dottori di ricerca, ricercatori, professori e a tutti gli studiosi accademicamente impegnati nell’insegnamento dell’architettura.
Per la pubblicazione sulla rivista cartacea l’articolo dovrà essere redatto entro il 02/03/2026 in forma di saggio scientifico, corredato da note, bibliografia e iconografia, per un massimo di 22.000 battute (spazi, note e bibliografia inclusi) e 7 immagini di cui si possiedano i copyright.
L’articolo proposto dovrà essere inedito, dai contenuti originali e mai apparsi in altra rivista a stampa o diffusione digitale o volume.
Tutti i saggi nella loro forma definitiva saranno sottoposti a procedimento di valutazione tra pari secondo i criteri della Double-Blind Peer Review.
stoà è una rivista scientifica di classe A per i settori 08/D1 progettazione architettonica e 08/E2 restauro e storia dell’architettura (Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 49 del 20 02 2025) e classificata come scientifica per le aree non bibliometriche 08 - “Ingegneria civile e Architettura” (Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 184 del 27 07 2023).